- 22 Novembre 2001
Tre interviste, in queste stesse pagine, in cui oltre che di voltagabbana si è riparlato dei tragici avvenimenti dell’assassinio di Aldo Moro. Prima Lanfranco Pace, l’uomo della trattativa fra socialisti e Brigate rosse, colui che faceva avanti indietro tra Signorile e il duo Faranda-Morucci. Poi Claudio Signorile, il vicepresidente del Psi che si oppose alla linea dura di Dc e Pci. Poi Adriana Faranda che recapitava per le Br le lettere di Moro. Qualche nuovo pezzo di verità: è stato Germano Maccari a uccidere Aldo Moro, erano frequenti gli incontri fra Pace e i brigatisti, i telefoni di Signorile erano sotto controllo, erano state le Br a chiedere il contatto. Non mi restava che andare a parlare con Valerio Morucci. «Su quello che avrebbe detto Maccari a Pace non posso dire molto perché Maccari a me questo racconto non lo ha fatto», dice subito Morucci.
Pace dice anche che non è entrato nelle Br perché la notte gli piaceva giocare a poker.
«Quello è il motivo per cui è uscito dalle Br, non quello per cui non c’è entrato».
Stai dicendo che era un brigatista?
«Nelle Br c’è stato poco. Il tempo di fare un’azione perché era alle sei di mattina. Ha giocato a poker tutta la notte poi è andato a bruciare la macchina di un caporeparto dell’Atac, se non ricordo male. Lanfranco era della Brigata Servizi. Dopo quell’azione ha cominciato a dare buche su buche».
Le mitiche Br hanno accolto un personaggio che tu definisci così improbabile?
«Lo portammo io e Adriana alle Br. Ce lo aveva chiesto lui. Era stato leader del Movimento del ’77 e fu accettato per l’importanza politica del suo ingresso».
E poi lo avete cacciato.
«Cacciato? Ha saltato un appuntamento, il recupero il giorno dopo, il settimanale, il mensile: chiuso».
L’intervista di Adriana è un racconto più intimo, la giovinezza, gli amori, la sua bambina. E il fatto che, proprio per non turbare questa bambina, quando stavate insieme, Adriana ti faceva uscire la mattina presto di casa.
«E io suonavo il campanello come fossi arrivato in quel momento».
Più borghesi non si può.
«Che c’entra? È un problema di salvaguardia della serenità dei bambini. Una cosa che hanno fatto migliaia di persone».
Quando eravate clandestini Adriana vedeva la figlia di nascosto. E tu vedevi i tuoi genitori. Clandestini ma indisciplinati.
«Non eravamo i soli».
Chi altro?
«Anche Mario Moretti».
Per vedere chi?
«Per vedere qualche donna. Era un marinaio Mario, aveva una donna, anche due, in ogni città».
Tu non avevi buoni rapporti con lui.
«Lui non aveva buoni rapporti con nessuno anche perché era il capo «supremo» quindi non poteva concedere nulla».
Era il capo supremo?
«Lui lo diceva e lo era di fatto. Anche se poi a sua insaputa fu messo sotto inchiesta. Lo avevano chiesto i capi storici, quelli che stavano in galera, agli altri tre dell’esecutivo Bonisoli, Azzolini e Micaletto».
E loro che cosa fecero?
«Cominciarono a fare il doppio esecutivo. Prima con Moretti e poi senza Moretti. Era una sorta di tentativo di estromissione, cosa che poi si è ricomposta. Ma Curcio e Franceschini non hanno mai sopportato Moretti».
Per quale motivo?
«Perché non era tra i fondatori. Perché aveva ancor meno elasticità politica. Ma per Franceschini anche per motivi più banali. Moretti era stato con Mara Cagol. Alberto era da sempre innamorato di Mara. Quindi, automaticamente, odiava Mario Moretti».
Signorile dice tre cose: primo, ho le prove che il mio telefono era sotto controllo; secondo, raggiungere le Br era facilissimo; terzo, siamo stati vicinissimi a salvare la vita di Moro, bastavano una maggior decisione da parte della Dc e una minor paura da parte delle Br.
«La prima cosa bastava».
Signorile si chiede: come hanno fatto le Br a sapere che Fanfani avrebbe parlato?
«Ma che discorsi. Ce lo aveva detto Pace. Noi ci siamo battuti alla morte nell’ultima direzione di colonna per aspettare la sortita di Fanfani. Ma Mario sosteneva che non potevamo rimanere invischiati nei traccheggiamenti della Dc. E alla fine tagliò corto: “La decisione è già stata presa”».
Signorile incontrava Pace, Pace incontrava voi, voi incontravate Moretti, Moretti incontrava l’esecutivo. Una polizia organizzata vi avrebbe preso tutti in tre giorni.
«Noi controllavamo Pace, poi controllavamo noi stessi, Mario anche si controllava. Non è così semplice come la mette Signorile».
Fu Pace che vi cercò oppure voi che cercaste lui?
«Sinceramente non me lo ricordo. Credo che ci abbia cercato lui».
Tu hai origini proletarie?
«Mio nonno aveva uno stabilimento di falegnameria in via Galvani al Testaccio, con tanti operai. Dal suo stabilimento sono usciti i portoni laterali dell’Altare della patria. Quando si rifiutò di iscriversi al partito fascista, lo stabilimento fallì. Mio padre andò all’Agfa. Ma fu licenziato perché non faceva il saluto romano. Nel ’49 fu assunto alle Poste. L’anno in cui nacqui io».
Tutti antifascisti?
«Mio nonno era anarchico. Andava con un gatto a nove code alle manifestazioni in piazza prima del ’22. Con lo stesso gatto ci picchiava i figli. Tutti comunisti, i figli. Sono nato e cresciuto comunista».
Scuole?
«Non mi andava di studiare. Facevo sempre sega».
Che cosa volevi?
«Volevo vivere. Studiare mi annoiava. Stare chiuso mi deprimeva. Mio padre mi iscrisse alla scuola alberghiera. L’estate lavoravo come cameriere. Alla fine mi assunsero al Cocktail Lounge di Fiumicino. Brigitte Bardot, Liz Taylor, l’avvocato Agnelli: facevo il cameriere dei supervip».
Avevi 18 anni.
«Guadagnavo una marea di soldi. Tra stipendi e mance, 200 mila lire. Ma era una vita infame: mi alzavo alle 5, lavoravo 11 ore al giorno. Mi licenziai. Cominciai a girare per Roma con una 850 Abarth e a frequentare i vecchi amici del liceo Mameli. Grandi discussioni, politica, sesso, psicoanalisi, linguistica».
Quali erano i tuoi miti?
«Steinbeck, Dos Passos, Hemingway, Garcia Lorca, Prévert, Dylan, Lucio Dalla. Ricordo come fosse oggi, Il cielo».
Poi arrivò il ’68.
«Ci siamo buttati subito dentro il movimento. Io che non andavo nemmeno al liceo, decisi che volevo andare all’università».
Valle Giulia?
«C’ero naturalmente. Ma rimasi sotto shock per un’oretta buona. E scappai. Ci rifugiammo dentro a un garage. Poi uscii e tirai il mio primo sasso».
Perché la contestazione ha perso subito la sua spinta creativa e spontanea?
«Perché il vecchio soffocò il nuovo. I leader non erano espressione di quel movimento. Russo, Piperno, Sergio Petruccioli, erano tutti ex dirigenti della gioventù comunista. Così il vecchio, gli irrisolti rimpianti comunisti, mise il cappello su quella che era una esplosione sociale».
Tu entrasti in Potere operaio.
«Mi diedero la responsabilità degli studenti medi. Mi diplomai alle magistrali e mi iscrissi a sociologia. Poi mi dissero di coordinare il servizio d’ordine. Le prime molotov».
Compito del servizio d’ordine era organizzarsi militarmente.
«Organizzare gruppi per andare a colpire degli obiettivi, compagnie aeree, uffici, ambasciate».
Non era uno strumento di difesa come si diceva.
«All’inizio. Se la polizia attaccava gli tiravamo le molotov. Però, datoche ne avevamo prese troppe, cominciammo a tirarle prima . Poi cominciarono le rapine. Poi, dopo le bombe sul treno degli operai di Reggio Calabria creammo una struttura di “lavoro illegale”. Me ne occupai io. Cercavo armi, esplosivo, appartamenti clandestini, documenti falsi».
La tua prima pistola?
«Una Mauser 6,35, vecchia come il cucco. Poi una Bernardelli 22, a tamburo, cromata col calcio bianco. Roba da checche di New Orleans».
Come «lavoro illegale» che cosa avete fatto?
«La prima gambizzazione d’Italia. Quando ancora le Br usavano la pece, noi sparammo alle gambe di un caporeparto fascista della Fatme di Roma. Fu Germano Maccari».
Come sei arrivato alla lotta armata?
«Passo, passo. Facemmo dei gruppi armati per intervenire nel sociale. Come quando, per sostenere il non pagamento delle bollette, mettemmo una bomba alla Sip».
Entraste vestiti da poliziotti.
«Un po’ di shampo secco sui capelli, un cappotto blu, il borsalino, gli occhiali. Ero un po’ giovane come commissario ma i metronotte ci sono cascati».
Hai detto: «Sicuramente abbiamo sbagliato i mezzi ma rivendico le cose che dicevamo».
«Non posso rivendicare le conseguenze, perché sono state aberranti. L’intento con cui eravamo partiti era difendere la vita, non ammazzare la gente. Ma rivendico la spinta che ci ha portato a fare quello che abbiamo fatto».
Oggi è diverso?
«Oggi è un incubo farsesco, ma il vero limite è stato toccato con i governi dell’ex sinistra. Cantava Jovanotti in una sua bellissima canzone che oggi le cose sono ancora più pericolose perché il nemico te lo porti dentro. Oggi non sai più con chi prendertela. Svanita ogni appartenenza di classe, ognuno è solo con se stesso».
Alle Br come sei arrivato?
«Litigavamo continuamente. Una scissione dietro l’altra. Volavano le sedie. Ci ho scritto un libro per far capire come è nata e cresciuta la lotta armata. Dopo l’ennesima spaccatura mi dissi: “Con le Br non sono d’accordo, ma la lotta armata noi non riusciamo a farla. E allora tanto vale farla con loro, per lo meno si fa qualche cosa invece di litigare dalla mattina alla sera”».
Tu hai ucciso delle persone.
«Sì».
Spesso si dice: «Curcio non ha ammazzato nessuno».
«L’aver fatto parte di una organizzazione che ha ucciso è una responsabilità collettiva e, nonostante la gravità, paradossalmente ci si potrebbe giustificare. Vabbé, noi abbiamo ucciso ma hanno ucciso anche loro. Prima che noi sparassimo un solo colpo di pistola c’erano stati 200 comunisti uccisi dalla polizia nelle manifestazioni dal ’45 in poi».
Aver sparato personalmente a una persona è diverso.
«È diverso. Sei da solo di fronte a un fatto concreto, enorme, drammatico. Ma il turbamento e il tributo che devo pagare per questo non deve interessare i lettori di un giornale. Nella manifestazione pubblica del cordoglio io ci vedo sempre ipocrisia e falsità. Se ci fosse da riempire il discorso sui rimorsi, io potrei farlo. Ma non prima che quelli che hanno mandato i nostri caccia a uccidere la gente di Belgrado abbiano fatto la stessa cosa».
I pentiti, si dice, sono i voltagabbana della lotta armata.
«Appiccicare categorie alla gente è pericoloso. Spesso i pentiti sono arrivati alla collaborazione dopo la tortura. Nelle bande armate vere, quelle sudamericane, non quelle alle vongole, all’italiana, l’unica cosa che si chiedeva a chi veniva preso era di resistere per 24 ore. Poi può parlare. Parlare sotto tortura non è tradire».
Stai parlando di torture.
«Ci sono stati dei processi. Ovviamente, essendo italiani, le torture non sono mai arrivate al livello sudamericano. Ma anche la tortura è relativa. In un Paese civilizzato in cui la violenza è contenuta possono bastare due schiaffi. È già tortura. Comunque anche qui si è arrivati alle sigarette spente sulla carne e a cose fatte sui genitali. In generale, dire che i pentiti sono dei voltagabbana è un’idiozia».
C’è chi si è pentito cinque secondi dopo la cattura.
«Quando quel cancello si chiude dietro le spalle, tronca il filo della continuità con quello che sei stato. Ti ritrovi in uno stato di azzeramento. L’inerzia viene spezzata. E ti poni le domande che non ti ponevi quando avevi una spinta enorme ad andare avanti. Chi si è pentito per l’effetto chiusura del cancello lo ha fatto perché ha perso la sua identità e l’unica identità alternativa a portata di mano era quella. Semmai voltagabbana è il dissociato. Tra i dissociati c’era una marea di gente che aveva fatto quella scelta per opportunismo, non per convinzione».
Tu eri un dissociato.
«E infatti mi sento un voltagabbana».
Ti senti, o lo sei?
«Non lo sono perché io sono uscito dalle Br prima dell’arresto».
E allora perché ti senti un voltagabbana?
«Perché si arriva a perdere la distinzione tra dissociazione e collaborazione. Ci sono dei momenti in cui il discrimine diventa labile. Io mi sento di aver tradito».
Chi è voltagabbana in Italia?
«Casa Savoia. Una casa regnante di voltagabbana. Vittorio Emanuele III. Finché avevano avuto dal Duce l’Impero, andava bene. Quando le cose non funzionarono più, alé, si va con i vincitori».
E oggi?
«Oggi indicare l’untore sarebbe un esorcismo. Come per Mani Pulite, è il sistema che è marcio. Io posso parlare dei nostri. Alberto Franceschini è un voltagabbana. È passato dalla parte dei nemici delle Br cioè i comunisti del Pci. Ha attaccato le Br dicendo che erano manovrate dai servizi segreti. Con la singolare tesi che fino a quando c’era lui le Br erano buone. Dimenticando quello che hanno combinato i capi storici incarcerati».
Che cosa hanno combinato?
«Agli atti del processo Dozier ci sono tutti i biglietti scritti di pugno dall’interno del carcere in cui si diceva: “Dovete ammazzare di più”».
Altri voltagabbana?
«Toni Negri. Ha inciuciato con la lotta armata e poi si è inventato la dissociazione».
Anche voi, quanto a dissociazione.
«Noi ci dissociavamo da noi stessi. Lui si dissociava da noi. La lotta armata? Io non c’entro niente. Si è fatto eleggere con i radicali dicendo che così avrebbe potuto far passare la legge sulla dissociazione. E poi se ne è scappato. Voltagabbana due, tre, quattro volte. Toni Negri non l’ho mai sopportato. Quando stavamo in Potere operaio prima, in carcere dopo. Ma tornando in Italia ha completamente riscattato le sue giravolte».
Hai mai capito come è avvenuto il tuo arresto?
«Una spiata. Mi servivano dei documenti falsi e mi rivolsi alla mala. Ma evidentemente qualcuno aveva rapporti con la polizia».
Se Moretti avesse chiesto a te di uccidere Moro che cosa avresti fatto?
«Non me lo avrebbe mai chiesto. Sapeva che ero contrario».
Ma se lo avesse fatto?
«Avrei detto no. La fedeltà al partito non poteva arrivare fino a quel punto.».
Com’è la tua vita oggi?
«Da sopravvissuto».
In che senso?
«Vivacchio».
Non hai lavoro?
«Nessuno ricorda i nomi del comitato esecutivo delle Br. Però loro hanno un lavoro e io no. Io mi sono esposto molto pubblicamente e ho pagato lo scotto».
La tua uscita dalle Br, con armi e soldi, ti aveva procurato difficoltà?
«Mi volevano morto. In carcere ce l’aveva con me soprattutto Franceschini. Voleva portare la mia testa su un piatto d’argento alle Br per convincerli a fare di più per loro. Ma Moretti disse di no».
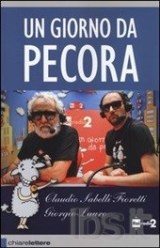
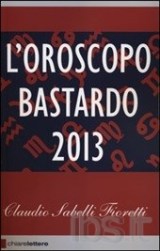







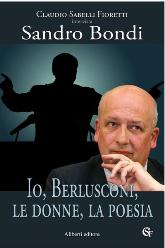
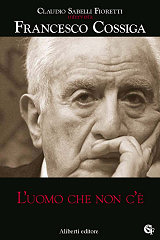

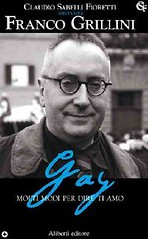



Nessun commento.