- 30 Settembre 1999
La sua rubrica si chiama Parolaio. Il lunedì, quando compare sulla Stampa, gli intellettuali di tutta Italia corrono a vedere se c’è il loro nome. Se c’è, è un guaio. Pierluigi Battista è una vipera. Usa il suo linguaggio soft ed elegante per seminare zizzania, attizzare polemiche, inchiodare i narcisi alle loro vanità, svelare gli errori prodotti da quella che definisce «la spocchia dei possessori di un ego troppo arroventato». Pierluigi Battista ha 44 anni. Il ’68 lo ha sorpreso al liceo Mamiani di Roma. La ventata di libertà lo convogliò in un gruppetto, Unità operaia, marxista-leninista.
Poi il Manifesto. Poi la rottura con la sinistra, la scoperta di Pannella e dei radicali. Per gli ex compagni diventò un traditore come Giuliano Ferrara, suo amico e «fratello maggiore», che lo ha portato con sé, condirettore, nella veloce avventura di Panorama. L’inchiesta di Sette sulla generazione che non sa invecchiare e sull’ old boys net individuata da Alberto Ronchey approda a lui. Consapevole che, nella migliore delle ipotesi, Battista dirà che tutto ciò che abbiamo scritto è privo di senso, lo incontro dalle parti di piazza Mazzini dove scopriamo comuni radici di oratorio (Cristo Re) e di scuole medie (Col di Lana). Non basta per salvarmi. Il primo obiettivo sono proprio io, colpevole di avere stigmatizzato l’atteggiamento voltagabbana di Giampiero Mughini, prima ferocemente comunista e poi ferocemente anticomunista.
«Sai perché mi hai fatto andare in bestia?».
Dimmelo.
«Tu te la prendi con quelli che passano dal comunismo all’anticomunismo… ».
No, quello che mi dà fastidio di quelle persone che Michele Serra ha definito «anguille» è il «ferocemente», prima e dopo. La rabbia del prete spretato.
«Ma non te la prendi con coloro che da fascisti sono diventati antifascisti. Come Ingrao. O che da democristiani sono diventati antidemocristiani. Come Fortebraccio. Uno è un percorso salvifico dalla nefandezza al bene. L’altro è il prete spretato».
La violenza con la quale le anguille attaccano gli ex compagni è insopportabile.
«Hai un pregiudizio negativo. lo sono incuriosito da chi è stato comunista e oggi dice: "Porca miseria, mi piaceva un regime che ha fatto fuori milioni di persone"».
Ma se tra l’essere comunista e il diventare anticomunista c’è la scelta di stare col vincitore?
«Tu stai pensando a Giuliano Ferrara. Anche tu gli rimproveri il fatto che i suoi "tradimenti" avvenivano a favore dei vincenti, Craxi e Berlusconi. Ma Giuliano è passato con Craxi molti anni dopo essere uscito dal Pci».
Ferrara non è un’anguilla. È un innamorato di sé. Si ritiene superiore sia a Craxi che a Berlusconi.
«A me sta più simpatico chi ha un atteggiamento dissacrante di chi vuole custodire l’ortodossia. In Francia si è spaccato un intero gruppo intellettuale su Solgenitsin. Le Roi Ladurie, Simone Signoret, Yves Montand, Edgard Morin, Furet. Jean-Paul Sartre, quando arrivarono i boat people vietnamiti, andò a chiedere scusa a Raymond Aron. In Italia solo Lucio Colletti si congedò dal marxismo».
Da chi avresti voluto reazioni?
«Dai più trasgressivi della sinistra, da Fortini, da Asor Rosa, da Dario Fo. Nulla».
I sessantottini che come te sono passati dall’altra parte rappresentano in qualche maniera una rottura.
«Bollati come traditori».
E che cosa t’importa?
«Mi dispiace che persone con le quali ho condiviso un’esperienza di felice eresia non abbiano saputo usare l’arma della critica ma solo quella della denigrazione».
Come dici nella tua rubrica: nomi.
«Gianni Minà. Una volta scrissi che a Cuba esistevano i prigionieri politici. Lui avrebbe potuto dire che era falso. Oppure che era vero ma era giusto. Invece disse solo che io ero un ex comunista deluso».
Veniamo ai sessantottini che Alberto Ronchey indica come assetati di potere, saldamente al potere, al timone di autorevoli giornali borghesi.
«Bene. TI risulta che Giulio Anselroi, direttore dell’Espresso, abbia avuto esperienze culturali e politiche simili a quelle di Nini Briglia, ieri Lotta Continua, oggi direttore di Panorama? Ti risulta che il direttore del Tgl, Giulio Borrelli, abbia avuto esperienze pari a quelle di Paolo Mieli, ieri Potere Operaio, oggi megadirettore della Rizzoli?».
Non mi risulta.
«I direttori importanti sono trenta. Venti non hanno fatto il ’68».
Ma dieci sì. Parliamone.
«Qual è il problema? A 50 anni si diventa direttori. Punto».
Tu hai scoperto il ’68 in una piccola formazione marxista-Ieninista.
«Eravamo sedici, o pochi di più. E facemmo anche una scissione».
Eri un sessantottino convinto?
«Certi slogan come "Fascisti, borghesi, ancora pochi mesi" oppure "Uccidere un fascista non è reato" erano un tormento. lo ero in lite con mio padre, che era borghese e fascista, ma non potevo pensare che dovesse essere ucciso».
Gli slogan sono metafore.
«Metafore truculente tipo "Almirante come Falvella, con un coltello nelle budella", "Camerata basco nero, il tuo posto è al cimitero". Sono cresciuto dentro quella tragica via Pal che era l’antifascismo militante. Le manifestazioni finivano regolarmente con l’assalto delle sedi del Msi. Barbara Palombelli nel suo libro difende i ragazzi di piazza Euclide. Dice che non erano fascisti. Erano fascisti, invece. Eccome. E picchiavano. Erano continue bastonate, da una parte e dall’altra. Anche nella sinistra estrema regnava l’arditismo, il dannunzianesimo d’accatto, la paura di apparire un intellettualino marcio».
E il clima di intimidazione che ha raccontato Silvia Ronchey?
«Nelle nostre assemblee non potevano parlare nemmeno i repubblicani».
Ricordi il linguaggio delle assemblee?
«Ricordo "Dico, cazzo, compagno". Frase perentoria, sottolineata col gesto di una mano, di taglio, che batte contro il palmo dell’altra mano. Poi: "La repressione passa sopra le nostre teste". E tutte quelle che rivelavano le appartenenze. "Metà studio e metà lavoro" era del Manifesto. "Prendiamoci la città" era di Lotta Continua».
E tutti dicevano: «Il privato è politico».
«Che dramma. Quando uscì La storia di Elsa Morante, nel 1974, ruppe finalmente il tabù per cui tutto era politica. Per non parlare di Porci con le ali. Era energia compressa che esplose. Non il romanzo in sé, ma il suo successo. Fu un caso di eterogenesi dei fini».
Prego?
«Fai una cosa e ottieni esattamente l’opposto. Lì nacque il riflusso. Perché non è vero che tutto è politico».
Arriviamo alla generazione che non sa invecchiare.
«Il ’68 non c’entra niente. È la civiltà dei consumi che non conosce più l’invecchiamento. È cambiato il mondo».
Sono anche cambiati i modelli che ci vengono suggeriti. Fustacchione, stangona, spensieratezza. L’Espresso lancia la Razza Brizzolata dove il modello è Galliani che siccome è ricco è anche giovane. E gioca al ragazzino con bandana in testa e fidanzatina al fianco. Ai tempi nostri, alla loro età ci si apprestava a morire.
«E che cosa c’entra il ’68? Ha fatto molto più il Gerovital del ’68».
Secondo te il ’68 non ha fatto niente. È scoppiato perché doveva scoppiare.
«Peggio. Essendo la prima generazione vitaminizzata, la prima che ha conosciuto le vacanze, che ha avuto la macchina a 18 anni, che ha potuto comprare tanti dischi, si è inventata i mitici anni ’60, costringendo quei poveretti dei figli ad ascoltare le canzoni di Gino Paoli. Ma ti ricordi? Dino. Adamo. Robaccia di infima categoria. Solo quel rigattiere di Fabio Fazio poteva ritirarle fuori».
Le canzoni del mitico ’68 erano altre. Contessa, Comandante Che Guevara, gli Inti Illimani.
«Diciamo la verità: dal punto di vista culturale il ’68 non ha prodotto nulla».
Beh, tutto era politica.
«Appunto. C’è un film, rispetto alla stagione del neoreaIismo, rispetto alla stagione della commedia all’italiana, che valga la pena citare?».
Serra dice che il ’68 era una pentola a pressione pronta a scoppiare.
«Sono totalmente d’accordo. Ma per me costituisce un problema il fatto che un fenomeno antiautoritario, libertario, trasgressivo, nel giro di due anni si sia messo a parlare il linguaggio dei regimi totalitari. I cinquantenni di oggi sono quelli che esaltarono la rivoluzione culturale cinese che aveva ammazzato milioni di persone. E se ne fregavano di Jan Palach, il ragazzo che si dette fuoco in piazza san Venceslao nel gennaio del ’69, per protestare contro la faccia violenta del comunismo. Per fortuna sono arrivati i favolosi anni ’80».
Favolosi?
«Il momento della liberazione per me. Io ero approdato al Manifesto, attirato da quel tanto di eresia che gli derivava dal ricordo dell’espulsione dal Pci. Ma nel 1976 non ne potevo più. Dio ti vede, Lucio Magri no. E votai radicale».
Che hai fatto nei favolosi anni ’80?
«Ho letto una quantità di libri interdetti. Mi sono tuffato nella letteratura, nei romanzi».
E poi?
«Ho conosciuto Giuliano Amato, Federico Mancini, Gino Giugni. Ho frequentato i miei fratelli maggiori, Ernesto Galli Della Loggia, Giuliano Ferrara, Paolo Mieli. Sai perché gli intellettuali di sinistra odiano terribilmente gli anni ’80?».
Dimmelo.
«Perché hanno dimostrato che il cambiamento veniva dalla parte opposta. Le grandi rivoluzioni degli ultimi vent’anni sono state fatte da Reagan, dalla Thatcher, dal capitalismo. È per questo che la sinistra è diventata conservatrice, proibizionista, sorvegliante, vietatrice. Esattamente come erano i reazionari negli anni ’50».
Che la sinistra abbia scavalcato a destra la destra mi pare una forzatura.
«Ma non vedi? Hanno nostalgia dei vecchi partiti che garantivano disciplina. Hanno paura dei giovani, del popolo, dei referendum, della tv, dell’America. La MeIandri vuole arginare le immagini che vengono da oltreoceano. Sono diventati conservatori quando hanno visto che la gente non voleva andare più in sezione ma alle Maldive».
Non sarà che la crisi della sinistra viene dalla volontà di mettere regole?
«Le regole, certo, le regole. Proibire. Vietare. È insopportabile».
Sei libertario, mica anarchico.
«Abbiamo migliaia di leggi! Ci sono i pedofili? Regole! Ma come? È già vietato violentare un bambino».
Sei mai stato comunista?
«Sì. Andavo all’ambasciata cinese a fare il carico degli stemmini di Mao Tse-tung. Ho fatto la diffusione militante di un quotidiano comunista, il Manifesto».
E pensavi che i ricchi fossero troppo ricchi e i poveri troppo poveri?
«l ricchi non mi sono mai stati antipatici. Non li odiavo».
E i poveri?
«Non amavo i poveri. Speravo diventassero ricchi».
E oggi?
«Penso che il comunismo abbia prodotto le più grandi miserie di massa della storia. E che il capitalismo democratico sia riuscito, al contrario, ad arginare la miseria».
Dove sei oggi politicamente?
«All’ala destra dei radicali».
Oddio. Taradasciano?
«No. Taradash si può seguire fino a un certo punto. Da An in poi bisogna abbandonarlo».
Sei stato condirettore di Panorama. Quando Alberto Ronchey parla di «old boys net» ti senti nel mirino?
«Vorrei chiedere a Ronchey: come si faceva carriera prima del ’68?».
Quindi fai parte del net.
«Il net non esiste. Cosa vuol dire Ronchey? Che a prescindere da differenze politiche esiste una solidarietà generazionale?».
Anche. Il caso Sofri ne è la prova.
«Non lo trovo scandaloso. Trovo scandaloso che alcuni dicano che non si può condannare sulla parola di un pentito, Marino, ma quando si tratta di un nemico politico ritengono che la parola di un pentito sia più che sufficiente per condannare. Doppio standard etico politico».
Di chi parli?
«Di Enrico Deaglio. Di Paolo Flores D’Arcais. Difendono giustamente Sofri. Ma nel caso di Andreotti la parola dei pentiti diventa sacra. Disonestà intellettuale».
Succede anche a destra.
«Non mi metti in difficoltà. È disonestà intellettuale anche quella di chi difende Previti e se ne frega di Sofri. A me piacciono i garantisti che difendono gli avversari. Poi c’è chi, come Di Pietro, è forcaiolo a 360 gradi».
Torniamo a Ronchey. È comprensibile che sia seccato nel vedere alla guida di giornali borghesi gli esponenti di quel movimento che lo bollava perché dirigeva un giornale borghese. Tutti di Lotta Continua.
«Ma sono cose successe trent’anni fa. E non è vero che sono solo di Lotta Continua. Posso fare un elenco di persone che stavano al Manifesto e sono ben piazzate nei gangli dell’informazione».
Facciamoli.
«No, mi scoccia perché uno è anche mio direttore».
Gianni Riotta?
«Appunto. Vorrei che non lo nominassi, ma è proprio così. Paolo Passarini: è stato vicedirettore della Stampa. L’ultimo scoop del Corriere della Sera l’ha fatto un ex giornalista del Manifesto che si chiama Carlo Bonini. Maurizio Caprara del Corriere viene dal Manifesto, come Stefano Marroni della Repubblica. E poi Alberto Flores».
I tuoi fratelli minori chi sono?
«A me piace molto Pietrangelo Buttafuoco che ha quasi dieci anni meno di me. Trovo bravissimo uno come Antonio Socci che sul Giornale scrive purtroppo di politica mentre sarebbe il più grande giornalista culturale di oggi. Massimo Gramellini, mio collega alla Stampa, un po’ più giovane di me, non ha una storia politica e fa osservazioni intelligenti e fresche».
Poi ci sono i tuoi coetanei.
«Ci vogliamo bene come persone che hanno fatto il militare insieme. Non abbiamo più niente da dirci, ma il rapporto è collaudato, il linguaggio comune rassicurante».
Chi per esempio?
«Lemer. Con Gad abbiamo spesso lavorato insieme. Si litiga, ci sono periodi in cui non ci parliamo. Ma rimane uno dei più stimolanti. Mughini. Non posso dimenticare quando rischiando di persona salvò da un linciaggio Duccio Trombadori all’università. Per quante cazzate Mughini possa avere scritto negli ultimi vent’anni, io gli vorrò sempre bene per quella scena lì».
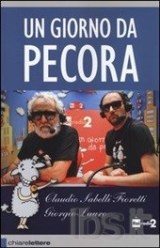
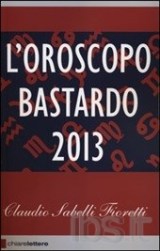







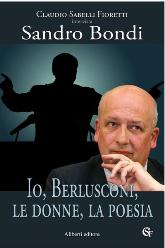
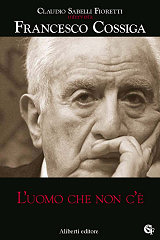

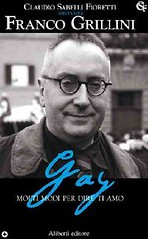



Nessun commento.